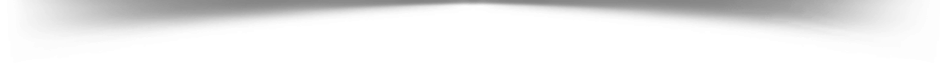Dietro la finestra chiusa
- DATE 12 Gen , 2021
- Author: sara
- COMMENTS Leave a comment
Si riparte.
Abbiamo mangiato la nostra pizza fuori.
Preso il primo aperitivo, distanti un metro, con le nostre mascherine.
Abbiamo rivisto amici che non vedevamo da tempo, riabbracciato i nostri cari.
Riaprono i parrucchieri, i ristoranti, persino le sagre.
Eppure penso a quelle finestre chiuse.
Quelle di quei numeri di cui ho parlato in un post, qualche settimana fa, per cui rivendicavo la pietà di un nome, del ricordo in quanto persone.
Quegli anziani, che un giorno sono andati a prendere con un’ambulanza, in due o tre, intabarrati in tute bianche, e che in quelle case non sono rientrati più.
Se ne sono andati, una mattina di marzo, circondati da sconosciuti.
I loro figli, se sono stati fortunati, se hanno trovato uno di quegli infermieri “eroi” di cui ci siamo già dimenticati, li hanno potuti vedere un’ultima volta sullo schermo di un tablet.
E sono morti soli, andando ad aumentare i numeri delle statistiche giornaliere.
Quando rispondevano a numeri reali.
E mentre finalmente passeggio insieme a mio figlio, chiedendogli di fare attenzione a non scontrare le persone, e ad attendere il suo turno ad entrare in un negozio, o bevo il mio caffè, in piedi, fuori dal mio bar preferito, il mio pensiero va a quelle case vuote.
A quei figli che dovranno svuotarle, ripercorrendo ricordi e memorie, che non hanno nemmeno potuto essere celebrate dignitosamente, con un ultimo addio.
Nessuno può scordarsi della fila di bare di Bergamo.
Nessuno uscirà indenne da questo periodo durissimo.
Ma c’è qualcuno che ha perso qualcosa in più, rimasto dietro ad una finestra chiusa.
(Foto dal web)
Tag
- fiducia
- musica
- vita da single
- vita
- 8 marzo
- Guerra
- Inverno
- winter
- Torino
- immigrazione
- Salone del libro
- burian
- frozen
- freddo
- Collaborazioni
- figli
- Pilates
- Bullismo
- Sport
- Benessere
- Ghost
- Film
- Alluvione
- Halloween
- Anni '90
- Moda
- Parigi
- Nonna
- Mostre
- discr
- violenza
- 25 Novembre
- andrà
- valigie
- gabbia
- camminare
- il corpo del
- G8
- incipit
- partenze
- tiger
- ridere
- decathlon
- dormire
- inizi
- fine
- mestruazioni
- love
- 11 settembre
- relaz
- rivoluzione
- politica
- social
- Gli invisibili
- aborto
- festa del papà
- black lives matter
- gabbiere
- felicità
- happinessa
- andràtuttobene
- Immuni
- Buenos Aires
- Migranti
- Letture
- maschere
- Serie TV
- Settembre
- Blog
- Ricordi
- amicizia
- Storie di Donne
- pregiudizi
- Pubblicità
- san Valentino
- Amsterdam
- Diritti
- paura
- ragazzi
- inaugurazione
- mare
- il corpo delle donne
- Ponte San Giorgio
- femminismo
- Ballate
- New York
- Anno Nuovo
- Libri
- Figli senza diritti
- Bellezza
- scrittura
- travelling
- lockdwon
- pride
- Morte
- Natale
- Famiglie arcobaleno
- DAD
- Gender
- Attualità
- Tempo
- Arte
- Racconti
- Ponte Morandi
- omofobia
- razzismo
- Vacanze
- monamour
- scuola
- covid
- Famiglia
- Genova
- Estate
- omosessualità
- lockdown
- Viaggi
- A come amiche
- Bambini
- Donne
- coronavirus
- quarantena
- D come donna
- Discriminazione
- Amore
- Maternità
- Lifestyle
- Relazioni
Articoli recenti
Categorie
×